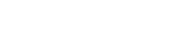Profili ricostruttivi in tema di simulazione di cessione d’azienda, collegamento economico – funzionale tra imprese, presunzione di solidarietà dei crediti e tutela reale
30 Aprile 2024|La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (26 gennaio 2024, n. 2526), ha confermato la decisione dei giudici di appello, richiamando il principio secondo cui il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (R. Foglia, L’evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria in materia di trasferimento d’azienda, in QDLRI, 2004, 197).
Sul punto, il Collegio ha precisato che tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
– unicità della struttura organizzativa e produttiva (F. Ferrara – F. Corsi, Gli Imprenditori e le Società, IX, Giuffrè, 1994, 162 ss.; V. Bavaro, Il trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda, in Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, a cura di P. Curzio, Cacucci, 2006, 238).
– integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
– coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
– utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente .
Sostiene la tesi dell’organizzazione M. Casanova, L’impresa e l’azienda, vol. X del Trattato di Diritto Civile Italiano, diretto da F. Vassalli, UTET, 1974, affermando che «l’azienda è l’organizzazione in cui si coordinano tutti i fattori della produzione e reali e personali (e perciò non solo cose, ma anche servizi) e non solo attuali, ma anche prospettivi».
L’Autore coerentemente afferma che «l’organizzazione o il complesso organizzato può dirsi tale e sussistere, solo in quanto integrale, ossia funzionalmente adeguato a conseguire l’intento per cui la coordinazione dei fattori organizzati è instaurata. L’espressione beni nella formula dell’art. 2555 c.c., viene perciò necessariamente ad assumere un’accezione amplissima tale da includere tutti gli elementi oggettivi, di qualsiasi natura, la cui globale combinazione serva alla esigenza e alla vita dell’impresa. È vero che contratti, crediti, debiti sono irriducibili ad elementi dell’azienda e ciò per la semplice e decisiva ragione che rapporti giuridici non sono né possono essere oggetti od elementi di oggetti. Ma, non per questo, debbono considerarsi estranei all’azienda, dato che proprio nell’azienda e nei suoi elementi, hanno il loro specifico oggetto o il loro punto di riferimento».
Prima di ricostruire le differenti questioni sottese alla pronunciai in commento, occorre premettere alcuni elementi salienti in fatto. In particolare, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in accoglimento dell’appello principale di in dipendente ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato al lavoratore appellante il 21/3/2012 dalla società datrice di lavoro; la Corte ha condannato le parti appellate alla reintegrazione del medesimo nel proprio posto di lavoro e al risarcimento in solido del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione come per legge; ha condannato le parti appellate in solido al versamento dei conseguenti contributi previdenziali e assistenziali. nonché al pagamento in solido delle spese di lite; ha rigettato l’appello incidentale.
La Corte di merito accertava la simulazione dell’atto di cessione di azienda del 19/7/2011 da una società semplice a una s.r.l. e l’interposizione fittizia della cessionaria nel rapporto di lavoro con l’originario ricorrente (e con il fratello del medesimo), con conseguente nullità del licenziamento in quanto ritorsivo; ciò al contrario del Tribunale, che, invece, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti dei soci della società semplice, escludendo un fenomeno successorio stante la cancellazione di tale società in data 18/1/2012, decaduto il lavoratore dall’impugnativa di licenziamento nei confronti dei soci della società semplice cancellata in quanto notificata alla stessa società, e dimostrata l’effettiva cessazione di ogni attività aziendale costituente la ragione formalizzata nell’atto di recesso, così escludendo che la finalità ritorsiva potesse essere qualificata come motivo illecito unico determinante.
Sul punto v. G.E. Colombo, L’Azienda, Volume III, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia diretto da F. Galgano, CEDAM, 1979.
Dopo aver esaminato e confutato le diverse teorie relative alla natura giuridica dell’azienda, l’Autore conclude che «l’azienda non rientra in alcuna delle figure dogmatiche tradizionali e riconosciute a livello legislativo: non in quella del patrimonio autonomo, né in quella dell’universalità di mobili, né infine in quella del bene unitario, materiale o immateriale. Essa costituisce quindi una semplice pluralità di beni, collegati alla persona dell’imprenditore in forza di diritti eventualmente diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento) e tra loro in fatto coordinati per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Ciò significa l’accoglimento della concezione che è stata chiamata atomistica».
Riguardo ai rapporti giuridici, ai crediti e ai debiti, considerati se non «beni aziendali» quanto meno elementi caratteristici dell’azienda dagli studiosi che si riconoscono nella teoria dell’organizzazione, l’Autore afferma che tale teoria sarebbe «certamente giustificata se i rapporti giuridici (contratti, crediti, debiti) si trasferissero necessariamente con i beni aziendali, non è invece fondata non solo (come appare ovvio) se dalle citate norme si desume che il trasferimento di quei rapporti giuridici non costituisce (almeno) effetto naturale dell’alienazione dei beni aziendali, ma nemmeno se da quelle norme si desume che il trasferimento dei rapporti giuridici è effetto solo naturale dell’alienazione d’azienda).
La Corte distrettuale, in estrema sintesi, ha fondato il nucleo delle proprie argomentazioni sulla ontologica natura simulata della cessione di azienda dalla s.s. alla s.r.l. e sulla ricorrenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, costituito dagli eredi del defunto titolare delle compagini sociali e dalle due società succedutesi nella titolarità formale dello stesso.
Per giungere a tali conclusioni, la Corte di merito ha espresso motivate valutazioni di fatto sui beni intestati alla s.s. ceduti, sulla vendita di terreni, sulla consistenza dell’attrezzatura meccanica e del bestiame e ha accertato che l’assegno di pagamento dell’azienda agricola ceduta dalla s.s. alla s.r.l. non era stato mai posto all’incasso; in base alla sovrapposizione teleologica e organizzativa tra le due società, ha ritenuto la s.r.l. un mero schermo giuridico frapposto tra la s.s. e i suoi soci da un lato, e i due dipendenti dall’altro, in stretta contiguità temporale con il palesarsi delle pretese creditorie di questi ultimi; esaminato il quadro fattuale e i documenti lavorativi raccolti, ha ritenuto provato che il rapporto di lavoro subordinato si era svolto alle dipendenze dell’unico centro di imputazione datoriale costituito dalle persone fisiche discendenti dai capostipiti e persone giuridiche da costoro costituite o promosse per utilità comuni.
Quale conseguenza dell’accertata simulazione della cessione aziendale e dell’accertata esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la Corte di Catanzaro ha ritenuto provato che la società semplice, a dispetto della sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, avesse di fatto continuato a operare e non poteva così essere considerata un soggetto giuridico estinto.
La Corte territoriale ha ulteriormente tratto la conseguenza che risultavano tempestive tanto l’impugnativa del licenziamento, ricevuta entro i 60 giorni sia dalla s.s. che dalla s.r.l., quanto la richiesta di esperimento di conciliazione, inviata ad entrambe le società entro i successivi 270 giorni. Il Collegio ha, quindi, tratto l’ulteriore conseguenza della ritorsività del licenziamento intimato dalla s.r.l., ritenendo l’intera operazione di costituzione della s.r.l. e cessione aziendale finalizzata al licenziamento dei lavoratori e alla creazione di uno schermo protettivo nei confronti delle loro pretese.
Avverso la predetta sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione
Di particolare pregio da punto di vista sostanziale e processuale è l’argomentazione della Corte con riguardo alle doglianze dei ricorrenti che lamentavano nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 414, 434 e 437, secondo comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Precipuamente, la contestazione derivava dall’accoglimento da parte della Corte di Appello della domanda di condanna diretta dei convenuti formulata per la prima volta in appello sulla base di una causa petendi nuova.
Essa avrebbe individuato l’azienda agricola nei terreni e la titolarità dell’azienda in capo non più alla società o ai soci ma in capo ai proprietari dei suoli in quanto successori o discendenti dell’amministratore della società, violando così il divieto di ius novorum in appello.
Tale motivo consente di prendere le mosse da talune innovazioni apportate dalla riforma del Diritto del Societario del 2003. Secondo il Collegio, il motivo non sarebbe fondato.
La Corte di legittimità, peraltro, aderisce ad un precedente e granitico filone giurisprudenziale, a partire da Cass. S.U. n. 6070/2013.
In base al medesimo, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Inoltre, benché, dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese estingua anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
La Corte ha enucleato in fatto le ragioni per cui ha ritenuto la simulazione della cessione e la sussistenza di unico centro di imputazione giuridica costituito da persone fisiche e persone giuridiche costituite o promosse per utilità comuni, e quindi provata, la suddetta “cancellazione della cancellazione” (A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 14ª edizione, Giuffrè, 1994, 582; per approfondimenti, R. Romei, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, in Comm Schlesinger, 1993, 211. G. Orlandini, Il trasferimento di azienda nelle imprese in stato di crisi tra dibattito teorico e prassi sindacale, in DLRI, 2005, 593).
La condanna solidale in capo alle persone fisiche e giuridiche costituenti il suddetto unico centro di imputazione datoriale non rappresenta, pertanto, secondo la Corte, accoglimento di una domanda nuova in appello, ma il corollario giuridico necessitato della suddetta ricostruzione in fatto e in diritto.
Di particolare interesse dogmatico è anche la deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla ricorrenza di unico centro di imputazione di rapporti giuridici, assumendo l’insussistenza di tale fenomeno unitario riferito ai rapporti di lavoro tra la precedente società semplice e la società di capitali costituita successivamente, trattandosi di legittimo fenomeno di trasformazione della veste sociale afferente alla libertà di iniziativa economica.
Si veda, in proposito, anche A. Boscati, La controversa qualificazione del ramo d’azienda, fra preesistenza qualificata e autonomia funzionale stabile e già compiuta, nota a App. Roma 7 ottobre 2013 e T. Ravenna 22 gennaio 2013, in ADL, 2014, 2, 442, cit.; P. Lambertucci, Il trasferimento di azienda in crisi, in LG, Gli Speciali, 2010, 67.
La Corte di legittimità sancisce – anche in questo caso – che il motivo non sarebbe fondato.
Sembra utile precisare come i giudici di merito, in sede di appello, si siano, infatti, conformati ai principi enucleati da un precedente filone ermeneutico di legittimità, secondo cui il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; che tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva (A. Caiafa, Le vicende economiche dell’impresa in crisi: diritto del lavoro comunitario e tutela del lavoratore, in DF, 2005, 558);
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 26346/2016, n. 19023/2017); ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (Cass. n. 7704/2018).
I ricorrenti deducevano, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1345 c.c., 18 della legge n. 300/1970, 115 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza gravata ritenuto sussistente l’intento ritorsivo pur in presenza di incontestata cessazione dell’attività imprenditoriale.
Secondo la Corte, tuttavia, anche tale doglianza non avrebbe avuto fondamento. In particolare, il collegio afferma che la cessazione dell’attività imprenditoriale al momento dell’impugnativa del licenziamento è stata esclusa in fatto dalla Corte di merito.
La Corte di Cassazione, nella ricostruzione motivazionale, prende le mosse da un orientamento di legittimità consolidato per cui l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (cfr. Cass. n. 23583/2019).
La Corte di merito, con motivazione congrua sulla base degli elementi probatori raccolti, ha ancorato la prova della c.d. ritorsività alla medesima costituzione della s.r.l., nonché alla simulata cessione aziendale immediatamente successive alle richieste di pagamento del controricorrente e del fratello in analoga condizione di rivendicazione di crediti lavorativi.
Si rinvia, in proposito, a U. Carabelli – B. Veneziani, Il trasferimento d’azienda in Italia, in La transmisión de empresas en Europa, Cacucci, 1999, 115. Per una panoramica sui primi commenti alla disciplina M. De Luca, Salvaguardia dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d’azienda: «funzione» del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce nella interpretazione della nuova disciplina nazionale (prime considerazioni sull’art. 47 della «legge comunitaria per il 1990»), in FI, 1991, IV, 287.
Si è invocata la tutela reale, inoltre, mediante la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, 1463 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte disposto la reintegrazione nonostante la materiale impossibilità giuridica e fattuale di giungere ad un ripristino del rapporto lavorativo alle dipendenze dei soggetti convenuti.
Tali doglianze non sono state considerate fondate dal Collegio, nella misura in cui la cessazione dell’attività è stata esclusa in fatto nel merito, mentre problematiche in sede di esecuzione o successiva liquidazione sono nuove e successive alla declaratoria di nullità del licenziamento con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di legge oggetto del presente giudizio.
Il Supremo Collegio, sulla base del ricostruito iter logico-motivazionale, pertanto, dichiara che i ricorsi devono essere respinti.
In conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato il principio generale per cui il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra.
Questo, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
– unicità della struttura organizzativa e produttiva;
– integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
– coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
– utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
In tale contesto, tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Ne discendeva, pertanto: da un lato, la tempestività dell’impugnativa del licenziamento, ricevuta entro i 60 giorni sia dalla cessionaria che cedente, e della richiesta di esperimento di conciliazione, inviata ad entrambe le società entro i successivi 270 giorni; dall’altro, la ritorsività del licenziamento intimato, in quanto l’intera operazione di costituzione di altra società e cessione aziendale era finalizzata al licenziamento dei lavoratori e alla creazione di uno schermo protettivo nei confronti delle loro pretese (G. Santoro Passarelli, Il trasferimento d’azienda rivisitato, in MGL, 1991, 464 ss.).
Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario
Visualizza il documento: Cass., 26 gennaio 2024, n. 2526
Scarica il commento in PDF
L'articolo Profili ricostruttivi in tema di simulazione di cessione d’azienda, collegamento economico – funzionale tra imprese, presunzione di solidarietà dei crediti e tutela reale sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.