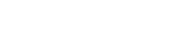La Corte di Giustizia interviene sul requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza da parte dei soggiornanti di lungo periodo
20 Agosto 2024|Contrariamente a quanto il nome iuris potrebbe far pensare, la misura introdotta nell’ordinamento italiano nel gennaio 2019 (e caducata dalla legge di bilancio 2023) non costituisce un reddito di base (basic income) erogabile a tutti i componenti di una determinata collettività per il solo fatto di appartenervi, ma rappresenta, piuttosto, un reddito minimo garantito (si veda Basic Income Network Italia).
Reddito di base e reddito minimo garantito sono, dunque, due misure radicalmente diverse poiché la prima è, per definizione, universalistica e spetta a tutti senza alcuna distinzione quantunque gli aventi diritto possano dirsi possidenti (ha efficacia erga omnes) mentre la seconda è selettiva (è una provvidenza destinata soltanto a coloro che stanno al di sotto della c.d. soglia di povertà) giacché richiede il soddisfacimento di determinati requisiti di accesso (S. Toso, Reddito di cittadinanza o reddito minimo?, Il Mulino, 2016, 14-16).
Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si è proceduto all’introduzione, in Italia, di un reddito minimo garantito e condizionato in quanto esso si indirizza ai nuclei familiari chiamati a soddisfare tutti i requisiti richiesti dall’articolato normativo (Si veda M. Ruotolo, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un’esistenza dignitosa, in DP, 2011, 410).
Inoltre, esso è – per espressa previsione normativa – una misura di politica attiva del lavoro, votata al reinserimento dei disoccupati (o all’inserimento degli inoccupati) all’interno del c.d. mondo del lavoro, sicché si atteggia a essere un provvedimento per certi versi proteiforme (Sul tema C. Tripodina, Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, 2015, 16).
Non sono mancate, ovviamente, levate di scudi in favore e a detrimento della misura, la quale potrebbe, per alcuni, scoraggiare le persone dal ricercare un’occupazione mentre, per altri, foraggerebbe i cc.dd. furbetti (Si veda M. Anselmo, E. Morlicchio, E. Pugliese, «Poveri e imbroglioni». Dentro il Reddito di cittadinanza, in “Il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica”, fasc. 1/2020).
Proprio i suoi tratti assai particolari (considerato che non rappresenta solamente un reddito minimo garantito ma, allo stesso tempo, non è soltanto una misura di politica attiva del lavoro in senso stretto) hanno originato non pochi contenziosi che, ovviamente, sono giunti sino alle magistrature superiori.
I giudici di merito, infatti, in diversi casi hanno ritenuto che taluni aspetti della disciplina fossero non in linea con i principi costituzionali nonché con il diritto eurounitario, muovendosi di conseguenza.
Così il reddito di cittadinanza è giunto, più volte, all’attenzione della Consulta la quale, ad esempio, ha sovente valorizzato la multiformità del reddito nostrano affermando, nella sent. n 126 del 2021, che: «Il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dal d.l. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro» (Corte Costituzionale, sent. 23 giugno 2021, n. 126 cit.).
Con riguardo al profilo che, in questa sede, interessa particolarmente, va detto (a titolo esemplificativo) che diverse pronunce della Corte costituzionale (decisioni nn. 122/2020 e 19/2022 oltre alla richiamata 126/2021) hanno ritenuto che non fosse irragionevole la richiesta – prevista dal legislatore – di un pregnante radicamento territoriale quale elemento concorrente alla possibilità di accedere al reddito, giacché quest’ultimo, per la Corte, non costituisce soltanto un mero sussidio economico ma rappresenta una misura ben più complessa e articolata: «non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue più ampi obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale» (Corte cost., sent. 19/2022, n. 5.2 del Considerando in diritto; si veda a commento D. Loprieno, Riflessioni sul reddito di cittadinanza e gli stranieri alla luce della sent. n. 19 del 2022 della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale fasc.3/2022).
Proprio quest’ultimo aspetto (radicamento territoriale) ha interessato la Corte di Giustizia, che si è pronunciata sulla disciplina nazionale posta a raffronto con i principi europei con particolare riguardo ai cc.dd. soggiornanti di lungo periodo.
Infatti, venendo ai fatti di causa, con le ordinanze del 16 febbraio 2022 (depositata il 17 febbraio 2022 – Causa C-112/22) e del 22 marzo 2022 (depositata il 29 marzo 2022 – Causa C-223/22), il Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, rispettivamente Ufficio IX e XIII, sospendeva due procedimenti penali in attesa della pronunzia da parte della Corte di Giustizia (i testi delle due sono pubblicati qui per completezza di riferimenti) sul rinvio pregiudiziale sottoposto a motivo di diversi dubia relativi all’interpretazione della normativa da applicare.
L’attenzione della Grande Sezione della Corte di Giustizia, pertanto, si è indirizzata a due cittadine di Stati non facenti parte dell’Unione ma beneficiarie dello status di soggiornanti di lungo periodo (ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003) che sono state accusate del reato di cui all’art.7, primo comma, del decreto-legge n. 4/2019 e s.m.i. giacché avrebbero dichiarato, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di soddisfare tutti i requisiti necessari al suo ottenimento, tra i quali la residenza decennale sul suolo italiano, incorrendo, in tal modo, nel reato di false dichiarazioni.
Infatti, l’art.7, primo comma, sanziona chiunque renda dichiarazioni false, utilizzi documenti falsi, ovvero attestanti cose non veritiere oppure ometta informazioni dovute e ciò al fine di percepire, in maniera indebita, il sussidio.
In forza di ciò, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha chiamato a rispondere le due cittadine straniere del sopradetto reato (che prevede la reclusione da due a sei anni) per avere percepito senza titolo la misura in questione.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo, nutrendo dubbi circa la sussunzione dei fatti all’interno della fattispecie incriminatrice come sopra descritta (con possibile non conformità del dato normativo nazionale al diritto dell’Unione) ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale, ex art. 267 TFUE.
Il combinato disposto dato dagli artt. 7, c. I, e 2, c. I, lett. a), del decreto-legge n. 4/2019, così, è stato posto a raffronto con il diritto eurounitario che si è assunto violato in diverse disposizioni dei Trattati, di regolamenti e direttive.
In particolare, il giudice rimettente chiede alla Corte di Giustizia, di pronunciarsi sulla corretta interpretazione con riferimento agli artt. 18 e 45 TFUE nonché all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e agli artt. 30 e 31 della Carta sociale europea, con particolare riguardo al requisito della residenza della cui legittimità dubita.
Chiede, altresì, pronuncia con riferimento all’ art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, e all’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 nonché, in ultimo, all’art. 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.
A detta del Tribunale, infatti, il legislatore nazionale – nel prevedere tra i requisiti legittimanti l’accesso la residenza decennale sul suolo italiano – costituirebbe, di fatto, una discriminazione indiretta in quanto concretizzerebbe un trattamento meno favorevole, specialmente per i cittadini di paesi terzi.
Il Giudice rimettente ricorda come la direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all’art. 11, par. 1, lett. d), stabilisce, espressamente, che il soggiornante di lungo periodo beneficia del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini nazionali anche con riguardo alle prestazioni sociali, all’assistenza sociale e alla protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.
Il Giudice non dubita che il reddito di cittadinanza sia ascrivibile all’interno del novero di misure elencate nella predetta lett. d) anche perché, a ben vedere, il legislatore nazionale qualifica, nominalmente, il sussidio quale livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili (art.1, primo comma, del d. l. n. 4/2019).
L’eventuale declaratoria di ostatività del diritto comunitario a una normativa nazionale, che preveda il requisito della residenza nei termini previsti, potrebbe, infatti, produrre la conseguenza di dequotare uno degli elementi essenziali del reato, degradando la fattispecie di reato a fatto non rilevante per l’autorità giudiziaria, con evidenti implicazioni per le cittadine chiamate a risponderne in sede penale.
Pertanto, il giudice domanda se il diritto unionale (nelle disposizioni sopra richiamate) osti a disposizioni nazionali volte a subordinare l’accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) rispetto a coloro che non possano vantare la predetta residenza decennale.
Nella ipotesi in cui la questione fosse risolta affermativamente, domanda, altresì, se il diritto eurounitario osti a disposizioni nazionali che riservino un trattamento deteriore ai soggiornanti di lungo periodo che acquisiscono tale status dopo la permanenza per cinque anni nello Stato membro di accoglienza e i soggiornanti di lungo periodo residenti sul suolo italiano da dieci anni (continuativamente per gli ultimi due).
Chiede, altresì, se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che impone l’obbligo di residenza per dieci anni al fine di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Domanda, infine, se il diritto UE si ponga in contrasto con disposizioni volte a obbligare i cittadini italiani (e dei paesi terzi) a dichiarare di aver risieduto per almeno dieci anni in Italia per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, con la conseguenza di poter incorrere in sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, anche in considerazione della finalità dello stesso reddito (Sembra qui utile richiamare le riflessioni su ius existentiae o ius ad vitam e, sul punto, G. Bronzini , Il reddito di cittadinanza, Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011, 18).
La sentenza della Grande Sezione del 29 luglio 2024 si articola in modo tale da passare in rassegna il contesto normativo, dando conto, poi, dei procedimenti principali e delle questioni pregiudiziali per approdare, indi, al procedimento innanzi alla Corte, con riguardo alla competenza, alle questioni pregiudiziali strettamente intese e infine alle spese.
Il dispositivo della sentenza dichiara che l’art.11, par.1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (che concerne lo status dei cc.dd. cittadini soggiornanti di lungo periodo) alla luce dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato come ostativo alla normativa di un paese membro che subordina l’accesso a una prestazione sociale al requisito della residenza decennale (applicabile, anche ai cittadini di tale Stato membro) e che punisce con sanzioni penali qualsivoglia falsa dichiarazione relativa alla residenza.
Al fine di ben comprendere lo stato dell’arte pare utile partire dal dato normativo nazionale che introduce e disciplina la misura di politica attiva del lavoro denominata “Reddito di cittadinanza” (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26), per poi passare in rassegna la domanda pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia, alla luce della normativa eurounitaria evocata e che si assume violata (artt. 18 e 45 TFUE; art. 34 CDFUE; artt. 30 e 31 della Carta sociale europea; art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011; art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE; art. 29 della direttiva 2011/95/UE).
Come detto, le domande di pronuncia pregiudiziale originavano da due procedimenti penali aventi ad oggetto false dichiarazioni per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza.
Risulta noto come, con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26), il Governo italiano ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza che, all’art. 1, primo comma, viene definito una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale».
Tra i requisiti previsti per l’ottenimento della prestazione sociale qui interessano, in special modo, i profili legati alla cittadinanza, alla residenza e alla permanenza sul suolo nazionale.
Infatti, l’art.2, primo comma, lett. a), nel definire i requisiti di accesso, prevede che il beneficiario debba, cumulativamente, essere cittadino italiano o di Stato membro o familiare di questi e titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Stato non membro dell’UE ma in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Alla lettera b), del medesimo articolo, è stabilito il requisito della residenza decennale sul suolo italiano, di cui gli ultimi due in modo continuativo (Sul radicamento e diritti sociali si veda S. Mabellini, Il “radicamento territoriale”: chiave d’accesso e unità di misura dei diritti sociali?, in ConsultaOnline, fasc. II/2022, pp.918-944).
Partendo da questo dato, il Tribunale chiama in causa il regolamento n. 492/2011 che, all’ art. 7, prevede che il cittadino di uno Stato membro non possa ricevere un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini degli Stati membri a motivo della cittadinanza, per quanto concerne le condizioni di impiego e lavoro […].
A ben vedere, tenendo conto del fatto che il reddito di cittadinanza è misura di politica attiva del lavoro, il richiamo a tale articolo potrebbe risultare utile, anche perché la giurisprudenza della Consulta, poco sopra richiamata, valorizza ampiamente questo dato e ciò è indice del fatto che viene data sufficiente considerazione al dialogo tra le Corti dei diversi ordinamenti interessati.
Il giudice, poi, richiama la direttiva 2011/95, laddove all’art. 29, par.1, prevede che ai beneficiari di protezione internazionale gli Stati membri debbano riconoscere «adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione».
La direttiva 2003/109, all’art. 4, par.1, prevede, inoltre, che gli Stati membri conferiscano lo status di soggiornanti di lungo periodo ai cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione ma che hanno soggiornato per cinque anni sul suolo di uno Stato membro in maniera legale e ininterrotta.
Come è noto il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo non deve gravare sul sistema di assistenza sociale del paese (dovendo dimostrare di possedere risorse sufficienti per sostentamento suo e dei suoi familiari nonché deve disporre di una assicurazione per i casi di malattia).
L’articolo 11 della direttiva stabilisce, quindi, il principio della parità di trattamento ai cittadini nazionali per quanto concerne «le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale» (lett, d), prevedendo che tale principio di parità possa essere limitato alle prestazioni essenziali.
Le interlocuzioni tra Corte di giustizia e giudice nazionale danno, inoltre, conto del principio di leale cooperazione tra le autorità giudiziarie interessate.
Infatti, come si evince dal testo della pronuncia, la Corte ha domandando al giudice rimettente di indicare lo status giuridico delle persone coinvolte nonché le disposizioni eurounitarie applicabili ai soggetti in esame. Il giudice rispondeva che trattavasi di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia.
A ben vedere la definizione di soggiornante di lungo periodo è rinvenibile all’interno della direttiva 2003/109 laddove, all’art. 4, par. 1, stabilisce che tale status sia conferito ai cittadini di Stati terzi soggiornanti legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni sul territorio di uno Stato membro.
La Grande Sezione della Corte di Giustizia, da conto della difesa prodotta da parte dello Stato italiano, a partire dalla contestazione della competenza della Corte a pronunziarsi sulla domanda avanzata.
Infatti, il Governo italiano afferma che le disposizioni legislative, da cui originano i fatti di causa e che si trovano all’attenzione della Corte, sarebbero state promulgate in virtù dell’esercizio di competenze esclusive dello Stato membro e, come tali, sarebbero sottratte al giudizio della Corte giacché il reddito non sarebbe solamente una misura di protezione sociale bensì una misura di più ampio respiro votata all’inclusione sociale e al reinserimento nel mercato del lavoro.
Torna, dunque, quanto sopra è stato già richiamato in ordine alla multiforme struttura del reddito di cittadinanza che è ben presente all’interno della giurisprudenza della Corte costituzionale.
La Corte di Giustizia, però, confuta l’assunto riguardante la competenza, ribattendo che l’interpretazione dell’art.11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109 rientra a pieno titolo nella competenza della stessa e prosegue affermando che, quandanche il reddito di cittadinanza non fosse compreso nell’ambito dell’art.11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109, tale argomentazione riguarderebbe il merito e non già la competenza dell’autorità giudiziaria adita.
Precisa, però, che la competenza della Corte di Giustizia debba arrestarsi sulla soglia della Carta sociale europea poiché, quantunque l’articolo 34, par. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si ispiri al trattato di cui sopra (che è bene ricordare rientra nell’ambito del Consiglio d’Europa), ciò non è idoneo a legittimare un raffronto tra le disposizioni evocate e la Carta sociale europea dal momento che l’interpretazione di quest’ultima esula dalla sua competenza.
La Grande Sezione, così, afferma la propria competenza a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale nella misura in cui le domande non involgano l’interpretazione della Carta sociale europea che, a ben vedere, viene pretermessa dal giudizio in parola.
La Corte passa, quindi, a scrutinare le questioni pregiudiziali sottoposte al suo apprezzamento.
Innanzitutto, richiamando il principio di cooperazione tra giudice unionale e giudice nazionale, afferma il proprio potere – se funzionale all’emanazione di un’utile risposta – a riformulare le questioni sottoposte al proprio giudizio, traendo gli elementi utili all’emanazione della invocata sentenza.
Tale precisazione si impone dal momento che, all’atto di introitare il rinvio pregiudiziale, il giudice di prime cure non precisava lo status giuridico delle cittadine del cui procedimento penale si trattava.
La Corte specifica che il Tribunale partenopeo, in risposta ai chiarimenti richiesti, affermava trattarsi, come più volte ricordato, di soggiornanti di lungo periodo.
Nel richiamare i chiarimenti richiesti al giudice nazionale, la Corte compie una scrematura tra le disposizioni che si assumono violate e quelle che, concretamente, riguardano il giudizio di rinvio pregiudiziale.
Orbene, afferma la Corte come la disposizione eurounitaria che, ai fini della richiesta pronuncia, deve essere presa in considerazione è l’art.11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109 così come filtrata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riguardante, precisamente, lo status giuridico degli accusati coinvolti nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (soggiornanti di lungo periodo n.d.r.).
Non rilevano, invece, gli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che, rispettivamente, recano la disciplina riguardante il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libera circolazione dei lavoratori nello spazio comune, che implica la caducazione di qualsivoglia discriminazione legata alla nazionalità e alle condizioni dell’impiego.
Non rileva, neppure, l’articolo 7, par. 2, del regolamento 492/2011 che vieta qualsiasi trattamento deteriore rispetto ai lavoratori nazionali in ragione della propria cittadinanza (Sul tema integrazione, migrazione e cittadinanza si veda AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, Atti del Convegno internazionale di studi Reggio Calabria, 26-27 marzo 2015, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro, Editoriale scientifica, 2016).
Infine, non conferente, a detta della Corte, è l’evocazione dell’art. 29 della direttiva 2011/95 che concerne l’assistenza sociale per i beneficiari di protezione internazionale da parte dello Stato che ha accordato la detta protezione con la conseguente limitazione prevista.
Al punto n.33 della sentenza, perciò, la Corte di Giustizia cristallizza l’oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale limitando il suo scrutinio all’art. 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109 «letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea».
Come più volte ricordato, il disposto della succitata direttiva, che assume rilevanza ai fini del decidere (art.11, par.1, lett.d), stabilisce il principio della parità di trattamento tra il soggiornante di lungo periodo e il cittadino nazionale per quanto riguarda «le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale».
Sembra utile ricordare come l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, alla luce dell’art. 6 del TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, al par. 3, afferma che l’UE, al fine di garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non hanno i mezzi sufficienti, «riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale».
Qualificata in tal modo la domanda del giudice di prime cure, la Corte afferma che la richiesta di rinvio pregiudiziale sottopostale debba essere intesa nei termini seguenti: «se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
Al punto 35, la Corte compie un’operazione di ermeneutica con riguardo ai concetti di “prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale” (Sui diritti multilivello, si veda L. Mariantoni, Eguaglianza delle persone, diseguaglianze nei diritti ed egualità del bilanciamento. Il (multi)livello di tutela dei diritti sociali, in Rivista AIC, fasc. n.3/2021).
A ben vedere, all’ operazione di esegesi la Corte antepone la premessa secondo la quale non spetta al giudice comunitario attribuire ai predetti concetti «una definizione autonoma e uniforme ai sensi del diritto dell’Unione» dal momento che il diritto UE ha inteso – riferendosi alla normativa nazionale – tenere conto delle differenze concettuali sussistenti tra le legislazioni dei vari Stati rispetto all’esatta portata ed estensione dei concetti in esame.
Ferma restando, dunque, l’insussistenza di un’autonoma definizione comunitaria delle nozioni di cui all’art.11, par. 1 cit., ciò – precisa la Corte – non può spingersi sino a esautorare l’effetto utile scaturente dalla direttiva richiamata.
Così inferendo la Corte statuisce che gli Stati membri, nell’approntare le misure di sicurezza sociale secondo la propria legislazione, devono rispettare il principio di non discriminazione sancito dall’ art.11, par.1, lett. d) della direttiva 2003/109 alla luce dell’art. 34 della CDFUE (punto 37).
La Corte, nel richiamare il dato letterale per mezzo del quale l’articolo 11 della direttiva (unitamente all’articolo 34 della Carta) rinvia all’ordinamento nazionale per la qualificazione delle nozioni in esso inalveate, afferma che spetta al giudice rimettente decretare se il reddito di cittadinanza sia incasellabile all’interno del novero delle prestazioni sociali propriamente intese e, come tali, facenti parte delle misure evocate dalla direttiva.
Questo dato, che costituisce un vero e proprio presupposto ai fini del decidere da parte della Corte, appare soddisfatto giacché il giudice del rinvio afferma che il reddito di cittadinanza si ammanta della qualificazione di prestazione di assistenza sociale e, come tale, rientra all’interno di almeno una delle nozioni (prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale) della direttiva richiamata (punti 18 e 39 della Sentenza).
La Corte, in sostanza, prende atto del fatto che il giudice nazionale ha ritenuto che il reddito di cittadinanza debba rientrare tra le nozioni aventi carattere sociale contenute all’interno dell’art.11 della direttiva, non avendo titolo per incidere sulla interpretazione del diritto nazionale offerta dal giudice rimettente in quanto la correttezza di siffatta interpretazione è questione che riguarda la giurisdizione nazionale ed esula dalle competenze riconosciute alla Corte di Giustizia.
Al punto 40, dunque, si limita a «prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio» e, nel fare ciò, deve assumere che il reddito di cittadinanza rientri tra le nozioni di cui all’art.11 della direttiva mentovata.
Il giudice del rinvio sembra aver tenuto in considerazione quanto affermava il compianto Stefano Rodotà vale a dire che «la materialità dell’esistenza esige che vengano presi in considerazione fattori che riguardano la persona nel suo rapporto complessivo con gli altri e con il mondo» (S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012, 233).
Al punto 42, la Corte passa a scrutinare la limitazione alla parità di trattamento che è consentita agli Stati membri, ex art. 11, par.4, della direttiva (fatte salve, però, le prestazioni essenziali di carattere sociale che devono essere garantite).
Orbene la Corte afferma che, secondo il giudice di prime cure, il legislatore non si sarebbe espressamente avvalso di tale limitazione e, a contrario, avrebbe espressamente qualificato il reddito di cittadinanza quale «prestazione essenziale».
A ben vedere il testo dell’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 4/2019 parla di «misura fondamentale» costituente «livello essenziale delle prestazioni».
A tale riguardo la Corte precisa come il concetto di prestazione essenziale «designa prestazioni che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare i suoi bisogni elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute», richiamando la propria giurisprudenza sul punto.
Considerato che questo punto ha interessato il Giudice delle Leggi italiano, sembra utile fare riferimento la sentenza n. 19 del 2022 della Corte costituzionale cit. dove si legge chiaramente, che «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale» (Corte cost., sent. 25 gennaio 2022, n. 19 cit., p.4 del Considerando in diritto).
La Corte UE, indi, richiama gli articoli 4, 5 e 7 della direttiva nelle parti in cui precisano le modalità, i requisiti e le procedure per l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.
A suo dire, anche tenendo in debito conto i considerando anteposti all’articolato normativo della direttiva, risulterebbe chiaro l’obiettivo per la quale è approntata e cioè di assicurare l’integrazione dei cittadini di paesi non facenti parte dell’UE ma stabilitisi al suo interno in maniera legale e ininterrotta, approssimando i diritti di questi ultimi ai diritti dei cittadini dell’UE, senza discriminazioni in ordine al trattamento.
Risulta di vivido interesse notare come la Corte di Giustizia richiami, a questo punto, la sentenza del 25 novembre 2020, nonché la propria giurisprudenza posta al punto 28 della pronuncia.
Come è noto la sentenza del 25 novembre 2020 concerne rinvio pregiudiziale sul medesimo articolo della direttiva qui esaminata con riguardo, però, al rigetto della domanda di assegno familiare avanzata da un soggiornante di lungo periodo per il periodo in cui la moglie e i figli hanno soggiornato nel paese di origine, dunque terzo rispetto all’Unione.
La Corte, in questa pronuncia, conclude affermando che l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (del 25 novembre 2003) osta a una disciplina nazionale che non prenda in considerazione, ai fini del riconoscimento di una prestazione sociale, i familiari del soggiornante di lungo periodo che risiedano nel paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di uno Stato membro residenti in uno Stato terzo, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale non abbia escluso tale possibilità, avvalendosi della deroga prevista all’art.11 della direttiva.
Al punto 47 della Sentenza qui in commento, la Corte passa in rassegna quanto avanzato dal giudice del rinvio e cioè se il requisito della residenza decennale sul suolo italiano avvantaggerebbe, a ben vedere, i cittadini italiani rispetto ai cittadini di Stati terzi.
Così, al punto 49, precisa che occorre verificare se il requisito richiesto possa configurare una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di Stati non facenti parte dell’UE aventi lo status di soggiornanti di lungo periodo.
Al punto 51 la Corte, prendendo le mosse dal concetto di discriminazione indiretta, afferma come non sia necessario, ai fini della qualificazione di discriminazione indiretta, che una misura sfavorisca tanto i cittadini nazionali quanto i cittadini di uno Stato terzo.
Infatti, anche i cittadini italiani, migrati all’estero e poi rientrati in Patria, potrebbero trovarsi nella condizione di non poter rispettare il requisito decennale richiesta con riguardo alla residenza.
Conclude, al punto 52, che il requisito della residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta, precisando, al punto 59, che essa contrasta con l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109.
Le discriminazioni indirette – come è noto – sono vietate a meno che non siano «obiettivamente giustificate» e abbiano come fine il raggiungimento di un «legittimo obiettivo».
La Corte da conto della posizione del Governo italiano che intende giustificare la scelta politica compiuta e la sussistenza di un legittimo obiettivo, poiché secondo l’esecutivo – precisa la Corte – questo obiettivo sarebbe rappresentato dal fatto che il reddito di cittadinanza non costituisce soltanto un mero sussidio bensì è una misura di politica attiva del lavoro che richiede il coinvolgimento dei componenti il nucleo familiare in un percorso di notevole complessità sicché questo sarebbe il motivo giustificante il dato della residenza decennale.
Richiamando, nuovamente, la sentenza del 25 novembre 2020, al punto 55, la Corte afferma che, con riguardo alla residenza, il paragrafo 2 dell’art.11 della direttiva preveda i casi in cui sia possibile derogare alla parità di trattamento e, comunque, che l’art.4, par.1, nel prevedere cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto per l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, testimonia, già, la volontà dell’Unione di prendere atto dell’inserimento del cittadino di uno Stato terzo nel paese membro, confermando una precisa scelta assiologica da parte dell’Unione e dando conto della sufficienza di tale periodo di tempo ai fini della parità di trattamento in ordine alle prestazioni sociali.
Dal momento che il considerando n. 12 della direttiva in questione afferma che lo status di soggiornante di lungo periodo rappresenta «un autentico strumento di integrazione sociale» (punto 58 della Sentenza), lo Stato membro non ha il potere di «prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest’ultima disposizione e l’obiettivo da essa perseguito».
La Grande Sezione, dunque, al punto 61 conclude affermando che l’art.11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109, così come letto in base all’art. 34 della CDFUE, osta «alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
Alla luce di questa breve disamina si può evidenziare come il requisito della residenza decennale in Italia, cui è subordinato l’accesso al reddito di cittadinanza per i soggiornanti di lungo periodo, si pone in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e, pertanto, occorre approntare le misure necessarie alla risoluzione del conflitto.
D’altro canto, la patente irragionevolezza del requisito in questione ha avuto la conseguenza di tagliare fuori dei potenziali beneficiari carenti della sola residenza decennale, con evidenti implicazioni in termini di eguaglianza sostanziale.
L’importante principio, affermato in favore dei soggiornanti di lungo periodo, è destinato ad avere conseguenze rilevanti sulla misura e su coloro che [non] ne hanno beneficiato, pur non avendo il requisito della residenza decennale.
Potrebbe, poi, prospettare, uno scenario di risarcimenti in favore di coloro che ne sono stati esclusi, e costituirà, certamente, un criterio guida per approntare misure similari al reddito di cittadinanza che non potranno recare disposizioni discriminatorie analoghe alle censurate.
In ultimo, al punto 60 la Corte, passa in rassegna l’armamentario sanzionatorio approntato dal decreto- legge, all’art.7, laddove prevede norme di carattere penale.
La Corte afferma che la sua costante giurisprudenza è univoca nello stabilire che un apparato sanzionatorio siffatto è incompatibile con la direttiva esaminata «quando è imposto per assicurare il rispetto di un obbligo che, a sua volta, non è conforme a tali disposizioni» che sarebbe come dire allorquando presidia un obbligo illegittimo e deriva la sua illegittimità dall’obbligo stesso che intende far rispettare.
Non si può tacere, a conclusione, come le norme penali, che hanno dato corso al rinvio pregiudiziale, esitato nella sentenza in commento, sono state interessate, in maniera alquanto peculiare, dal reddito di inclusione che ha preso il posto del precedente sussidio (legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1 c. 318).
Infatti il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, statuisce l’applicazione delle disposizioni penali di cui all’art. 7 del decreto istitutivo del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, nonostante il legislatore, con la legge di bilancio 2023 poco sopra richiamata, abbia abrogato, in toto, reddito e pensione di cittadinanza con il corredo di norme sanzionatorie poste a presidio delle stesse (su questo interessante profilo si vedano L. Messori, Risvolti intertemporali dell’abrogazione del reddito di cittadinanza e dell’introduzione del reddito di inclusione: una deroga ragionevole alla retroattività favorevole con il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, in Giurisprudenza Penale, fasc. 6/2023 e anche G. L. Gatta, Reddito di cittadinanza e “abrogatio per aberratio” delle norme penali: tra abolitio criminis e possibili rimedi, in Sistema penale, fasc.3/2023).
Anche questo aspetto è destinato a sollevare non pochi dubbi, attese le sue conseguenze non solo dal punto di vista del diritto intertemporale, offrendo materia di riflessione e di discussione da parte di dottrina e giurisprudenza.
Per concludere, la sentenza della Corte di Giustizia afferma un importante principio in favore dei soggiornanti di lungo periodo, che avrà rilevanti conseguenze, ricordando al legislatore nazionale come le discriminazioni indirette sono vietate e debbano essere eliminate e richiama l’importanza della vocazione inclusiva dell’Unione, troppo spesso tacciata di essere un club di banchieri e burocrati.
Angelo Ventura, dottore di ricerca in diritto ed economia
Visualizza i documenti: Trib. Napoli, sez. GIP, ordinanza 17 febbraio 2022 (causa C-112/2022); Trib. Napoli, sez. GIP, ordinanza 29 marzo 2022 (causa C-223/2022); C. giust., Grande Sezione, 29 luglio 2024, cause C-112/22 e C-223/22
Scarica il commento in PDF
L'articolo La Corte di Giustizia interviene sul requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza da parte dei soggiornanti di lungo periodo sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.