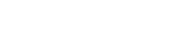La Cassazione ritorna sul formalismo della notifica a mezzo PEC contenente un atto in formato telematico errato
8 Settembre 2024|1. La vicenda
La Corte di appello di Venezia aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione della sentenza di primo grado poiché l’appellante aveva notificato, a mezzo PEC, non la copia dell’appello depositato, bensì, erroneamente, quella del ricorso introduttivo del giudizio.
Il giudice veneziano, in particolare, aveva richiamato un precedente della Cassazione (ord. 30044/2022) che aveva dichiarato inesistente la notifica in un caso analogo.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione svolgendo tre motivi. Le controparti avevano resistito con controricorso, depositando anche memoria. La Corte si era riservata la decisione con ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis.1 cpc.
Con il primo motivo (svolto ex art. 360, n. 3) si lamentava la violazione dell’art. 156 cpc, sottolineando come il giudice di merito non avesse tenuto conto della diversità del caso specifico con quello deciso dal citato precedente di cui all’ordinanza 30044/2022, dove invece era stata dichiarata la irritualità della notifica in quanto l’appellato si era costituito al solo fine di farne accertare l’inesistenza.
Nel caso in esame, invece, gli appellati non si erano limitati a eccepire la ritenuta inesistenza della notifica, ma avevano anche svolto difese nel merito, prendendo visione del ricorso in appello depositato nel fascicolo telematico, del quale, evidentemente, era stata chiesta la visibilità.
Né conseguiva, da un lato, l’effettivo instaurarsi del contraddittorio e, dall’altro, l’errore di allegazione non aveva comportato un allungamento dei tempi processuali.
Con il secondo motivo (formulato ex art. 360, n.5 cpc) si sosteneva, sotto un altro profilo, l’omesso esame del fatto costituito dalla già dedotta idoneità dello svolgimento delle difese nel merito, da parte dell’appellato, sufficiente, ad avviso del ricorrente a superare il vizio di notifica verificatosi.
Nel terzo motivo (formulato qui, ex art. 360, n. 5, in connessione con l’art. 132 cpc) si denunciava altresì la nullità della sentenza per non essersi la Corte di merito pronunciata neppure sulla questione della difesa nel merito fatta dall’appellato.
2. La decisione
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento dei successivi due.
Viene innanzi tutto richiamata la sentenza delle Sezioni unite n. 14916/2016, dalla quale risulta che l’inesistenza della notifica costituisce, nell’ordinamento processuale, un’ipotesi “residuale” che ricorre, oltre che nel caso di mancanza materiale dell’atto, anche dove l’interessato proceda alla notifica di un atto del tutto privo degli elementi strutturali finalizzati a renderlo riconoscibile dal destinatario.
L’inesistenza, prosegue la Corte, “non è dunque, in senso stretto, un vizio più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto (così S.U., p. 8, § 2.3)” (sul punto, in generale, v. FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, ESI, 2023 e, specificamente sulle notifiche, DE NOTARISTEFANI, I vizi delle notifiche, principi e casistiche, Exeo ed., 2022).
In tal senso, la Corte, nella pronuncia 30082/2023 ha chiarito che nell’ipotesi di notificazione a mezzo PEC regolarmente pervenuta al destinatario, dalla quale risultino chiaramente gli estremi essenziali della notifica (soggetto che la esegue, destinatario e finalità della notifica stessa), ogni difformità degli allegati (atti e relata di notifica) determina la nullità e non l’inesistenza della notificazione.
Analogamente, con la pronuncia 4902 del 2024, che ha deciso un caso simile a quello qui esaminato, si è precisato che nel rito del lavoro, ove l’appellante abbia proceduto al deposito del relativo atto, la mancata allegazione dello stesso al momento della notifica, comporta unicamente la nullità dell’atto e non la sua inesistenza a condizione che il messaggio ricevuto dal destinatario contenga gli elementi essenziali a comprendere le finalità della comunicazione.
In quel caso si era verificata una situazione similare, posto che l’appellante, depositato il ricorso e verificata la fissazione dell’udienza da parte del Presidente, ha regolarmente attivato la trasmissione a mezzo PEC secondo le regole processualmente corrette: «[i]l mittente e il destinatario erano i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente», sottolinea la Corte, «come documentato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC». Aveva però errato, allegando il ricorso introduttivo al posto di quello di appello.
La Corte rileva come non fosse in discussione che la comunicazione trasmessa via PEC contenesse tutti i dati necessari per comprendere la provenienza dell’atto dalla parte interessata all’appello, il nominativo degli appellati e l’oggetto della notifica «(ricorso in appello per la riforma della sentenza del Tribunale)».
Sulla base di tali dati gli appellati avevano potuto visionare e prendere conoscenza dell’appello, depositando costituzione e svolgendo difese nel merito, oltre a eccepire l’inesistenza della notifica.
In tale situazione risulta difficile, secondo la Corte, ravvisare la dedotta inesistenza della notificazione, posto che l’allegato erroneo non impediva ai destinatari di avere conoscenza dell’esatto oggetto della comunicazione, escludendosi quindi «che possa ravvisarsi un’ipotesi di “totale mancanza dell’atto”, da intendersi come atto notificatorio e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale (così Cass. 4902/2024)».
Tanto trova fondamento nel principio della «strumentalità delle forme degli atti processuali» che caratterizza il Codice di procedura civile. Dal che ne deriva come le forme degli atti debbano essere valutate come conformi o meno alla funzione cui sono destinati nell’ambito del processo, il cui scopo ultimo è quello di giungere alla pronuncia sul merito della situazione controversa «quale valore tutelato dall’art. 11 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. Cass. S.U. n. 18916 del 2016, cit., pag. 9, § 2.4 e precedenti ivi richiamati)» (sull’art. 6 CEDU, v. BUFFA, Forme e formalismo tra Cassazione e Cedu, QG, 12.12.2022).
Le citate SS.UU. 18916/2016, hanno fatto applicazione di tali principi, nell’esaminare il caso costituito da un ricorso per cassazione di cui la copia notificata (lì a mezzo del servizio postale) risultava senza una o più pagine, cui era seguito il deposito dell’originale in forma integrale.
In quel caso è stata esclusa l’inammissibilità del ricorso, riconducendola ad un vizio di notifica sanabile, «con efficacia ex tunc», mediante una nuova notifica di copia integrale da parte del ricorrente ovvero nel termine fissato dalla Cassazione o, ancora, a seguito della costituzione del controricorrente, cui va concesso, occorrendo, un termine per integrare le sue difese (la Corte cita anche un ulteriore precedente, costituito da Cass. 2537/2022).
Dunque, nel caso in esame, poiché le informazioni desumibili dall’atto notificato risultavano idonee a consentire alla controparte di accedere al fascicolo, di prendere visione dell’allegato mancante e consentire le difese nel merito, va dichiarata la nullità e non l’inesistenza della notifica, sulla base del seguente principio: «17. Alla luce dei principi di diritto richiamati e superata la diversa opzione espressa dalla ordinanza n. 30044 del 2022, deve ribadirsi che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un’ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell’impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata)».
La sentenza viene così cassata e rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
3. Gli ulteriori precedenti della Corte
Non dissimile è il caso trattato da Cass. 16788/2024, nel quale si trattava della notifica via PEC ai fini della decorrenza del termine breve di una sentenza non in formato ELM, prodotta unitamente alla stampa delle ricevute di avvenuta consegna indirizzate ai difensori in primo grado. Aveva osservato il giudice di merito che l’appellato non aveva dato prova della notifica della pronuncia di primo grado, finalizzata a far decorre il termine breve per l’appello, non avendo prodotto «il file in formato EML, al fine di consentire al giudice di verificare la relata e il contenuto della notifica (che avrebbe dovuto essere la copia conforme della sentenza) oltre alla ricevuta di consegna. Non era stata provata, pertanto, la dedotta violazione del termine breve». L’appello era dunque ammissibile non risultando superato né il termine breve che quello ordinario.
La sentenza impugnata, dunque, sosteneva la mancata prova della notifica della sentenza per la sola mancanza del deposito dei file in estensione EML, ritenuto necessario per verificare la relata e il contenuto della notifica, senza tenere conto che la ricezione della PEC con l’allegata sentenza del Giudice di pace era stata ammessa nel giudizio e, peraltro, risultava pacifica anche nel controricorso depositato in cassazione.
Nei suoi precedenti (SS.UU. 23620/2018), la Corte aveva già chiarito che «l’irritualità della notificazione a mezzo di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».
Nel caso esaminato dalle Sezioni unite, mancava nell’oggetto del messaggio via PEC la dizione «notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994» e l’indicazione del codice fiscale del soggetto notificante, risultando pacifica l’avvenuta notificazione: tali mancanze, ad avviso della Corte, costituiscono semplici irregolarità, qualora risulti pacifica tra le parti l’avvenuta notifica dell’atto.
Altresì la Corte, nella pronuncia 10138/2022, aveva ritenuto idonea, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, la notifica di copia della sentenza priva dell’attestazione del cancelliere della conformità all’originale dell’atto. In questa ipotesi, considerata la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 cpc. e tenuto conto che la comunicazione era avvenuta via PEC senza che la parte interessata avesse dedotto la difformità tra la copia notificata e l’originale, la circostanza viene ritenuta non rilevante.
Ancora, la Corte, con l’ord. 20214/2021, aveva chiarito che la violazione delle forme digitali nel caso di notifica dell’atto non ne costituisce causa di inesistenza, bensì la sua nullità che, come tale, ben può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. Nella specie, l’atto irregolarmente notificato era stato rinviato dal destinatario dello stesso al notificante su sua espressa richiesta, così rendendo inconfutabile il suo regolare ricevimento.
4. Osservazioni conclusive
La sentenza in commento e gli altri precedenti che si sono visti, al di là della particolarità dei singoli casi esaminati, risultano interessanti per la conferma dei principi generali in tema di nullità degli atti processuali e della loro sanabilità, ponendosi in continuità con i principi generali stabiliti dalla legge.
L’art. 156 cpc, «[r]ilevanza della nullità» prevede che «1. [n]on può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 2. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». A tale norma, del resto, venendo alla specifica questione qui approfondita, fa espresso riferimento l’art. 160 cpc che tratta della regolarità della notifica.
Vero è che la notifica a mezzo PEC può presentare insidie, trattandosi di comunicazioni a cui, generalmente, è allegato un atto che deve avere certe caratteristiche, con la possibilità, quindi, di errori nella stessa allegazione (PALERMO, Notifica a mezzo posta elettronica certificata. Insidie e opportunità, Ed. Il Papavero, 2021) che possono comportare l’invalidità dell’atto.
Soccorre, in tal caso il citato art. 156 cpc, con la conseguenza che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, determinando così il raggiungimento dello scopo previsto dall’ordinamento.
Più in particolare, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione, qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione, con la conseguente sanabilità dello scopo cui è finalizzata la comunicazione.
Principi generali, dunque, quelli della conservazione dell’atto (PICARDI, Manuale del processo civile, Giuffré, Milano, 2013, pag. 269), che vengono opportunamente ribaditi dal giudice di legittimità nei casi ricordati.
Ovviamente diversa è la situazione in cui l’errore riferibile all’allegato comporti l’assoluta incertezza per il destinatario sulle finalità della notificazione (sotto profili non dissimili si veda anche MENGALI, Notifica del ricorso in appello: la Corte di cassazione conferma che è solo l’inesistenza della notifica a rendere il gravame improcedibile, rivistalabor.it, 31.1.2022).
Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 1° luglio 2024, n. 17969
Scarica il commento in PDF
L'articolo La Cassazione ritorna sul formalismo della notifica a mezzo PEC contenente un atto in formato telematico errato sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.